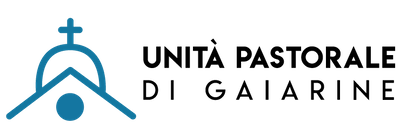Parrocchia di Campomolino
La Chiesa di Campomolino ha origini molto antiche come dimostra un documento del 1295 che cita Terra Sancti Laurenti de Campomolino.
L’indagine archeologica realizzata durante gli ultimi lavori di restauro (1998-2001) ha confermato un impianto antico costruito su una precedente struttura di età romana poi distrutta a causa di un incendio.

La prima chiesa fu ampliata in pianta sul finire del ‘500 e, nel secolo successivo, fu costruito il campanile al suo interno.
L’attuale forma e gran parte delle finiture, derivano dagli interventi di restauro e trasformazione della metà del ‘700. In questo periodo la chiesa fu infatti sopraelevata e realizzato il soffitto che fu poi affrescato da E. Dall’Oglio. Nello stesso periodo fu realizzata la cantoria sopra l’ingresso principale dove ha trovato posto l’organo di A. Da Re.
Il campanile, che agli inizi del ‘900 si trovava ancora all’interno della chiesa posto nell’angolo sinistro della facciata, fu demolito e riedificato all’esterno a pochi metri dalla posizione originale.
Il restauro
La Chiesa di San Lorenzo è una delle poche strutture pervenute fino ai nostri giorni incontaminate dai restauri dell’Ottocento e Novecento.
L’interno dell’edificio presenta un’unica navata divisa dal presbiterio da una balaustra e da tre gradini e conserva quasi tutte le opere d’arte con cui è stato ornato nei secoli.
Capitello dedicato alla B.V. Maria Ausiliatrice e a S. Giovanni Bosco e breve storia del Molino Santuz
Il Capitello fu costruito nell’anno 1966 dai F.lli Santuz, nel segno della devozione che è propria della loro famiglia. Si trova in località ‘Restejuzza’, nella frazione omonima del territorio comunale di Gaiarine, tuttavia i residenti della borgata storicamente sono da sempre collegati con la parrocchia di Campomolino.
Nelle immediate adiacenze sorge tuttora lo storico edificio del molino azionato ad acqua, condotto per lunghi anni dalla stessa famiglia in capo a più generazioni. Le operazioni tipicamente svolte erano la molitura dei cereali, la trebbiatura e l’aratura dei terreni per conto terzi. Un trafficato centro di attività connesse a sostegno dell’agricoltura insediata nel vicinato.